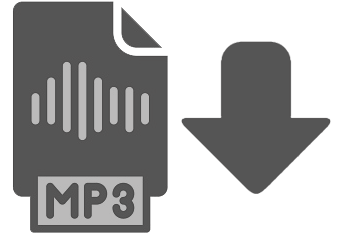Carl Rogers è convinto che il lavoro dei gruppi d’incontro serva a curare la società, a farla funzionare meglio, infatti si è rivelato utile allorché applicato in vari settori. Nella chiesa, dove è stato adoperato ampiamente per «instaurare quel senso della comunità che manca così spesso», per promuovere la partecipazione dei parrocchiani, migliorare la comunicazione con i pastori e unire vecchie e nuove generazioni. Nell’apparato statale, anche se nel corso degli anni Sessanta è stato piuttosto raro, per migliorarne l’organizzazione e favorire «un tipo di leadership governativa più libera, meno autoritaria, più comunicativa». Nei rapporti razziali, anche qui poco utilizzato, per «dirimere le tensioni tra gli individui e tra i gruppi», ma non con l’obiettivo di attenuare le tensioni, ma per far progredire la comunità ed eliminare i peggiori ostacoli all’eguaglianza razziale. E poi nelle famiglie, nel gap generazionale, nelle tensioni internazionali. Ma soprattutto in due ambiti su cui Rogers si sofferma maggiormente, quello industriale-aziendale, luogo dove più che altrove sono stati sperimentati i gruppi d’incontro, e la pubblica istruzione. In ambito scolastico Rogers fornisce alcuni esempi che lo hanno visto coinvolto in prima persona, come l’intervento del Center for Studies of the Person, nel 1966, per applicare questo “strumento di cambiamento sociale” in un complesso scolastico (comprendente college femminile, scuole medie ed elementari) gestito dall’Ordine cattolico del Cuore Immacolato. Oppure il Project Transition attuato a fini anni Sessanta nelle scuole di Louisville in Kentucky ldove era alto il numero di bambini provenienti da famiglie povere e negre. Tra le finalità del programma di lavoro di gruppo ci sono la «rieducazione degli insegnanti perché acquisiscano le doti interpersonali necessarie a instaurare con gli allievi rapporti che offrano loro maggior sostegno ed empatia», oppure la «creazione di corpi insegnanti in cui vi sia equilibrio razziale, tali da costituire modelli viventi di migliorati rapporti umani».
In campo industriale, Rogers cita uno degli esempi a suo avviso più ingegnosi in cui si è fatto un uso intensivo dei gruppi, la TRW Systems (grossa società che produce «complicati elaboratori dell’era spaziale») per affrontare i problemi psicologici e le preoccupazioni del personale in occasione della fusione tra due società. I National Training Laboratories hanno lavorato molto con aziende soprattutto in programmi di sviluppo organizzativo, puntando a una serie di obiettivi che comprendono la creazione di un clima di franchezza, l’integrazione tra autorità derivante da funzione o status e quella del sapere e delle capacità, avvicinare responsabilità decisionali e soluzione dei problemi alle fonti d’informazione, instaurare un clima di fiducia, «indirizzare maggiormente la competitività verso gli obiettivi di lavoro ed esaltare gli sforzi di collaborazione», «realizzare un sistema di ricompense a riconoscimento dei risultati ottenuti», «accrescere nei lavoratori il senso di “appartenenza” degli obiettivi dell’organizzazione», aiutare i dirigenti a operare in modo pertinente e non ricopiando quanto già fatto in passato, infine «accrescere l’autocontrollo e l’autodirezione per il personale nell’ambito dell’organizzazione». (Carl Rogers, I gruppi d’incontro, pp. 134-145)
Tali benefici emergono anche dall’analisi allora più completa sugli effetti dei gruppi d’incontro, quella di Jack Gibb pubblicata nel 1970 (“The Effects of Human Relations Training”, in Handbook of Psychotherapy and Behavior Change), che dopo aver preso in esame centinaia di studi conclude: «Le esperienze intensive di addestramento di gruppo hanno effetti terapeutici», sebbene Rogers preferisca evitare quest’ultimo termine e parlare di «stimolo psicologico all’accrescimento». Secondo Rogers uno dei dati principali che emerge tanto da questi studi quanto dalle sue molteplici esperienze, è l’evoluzione positiva riscontrabile nei singoli partecipanti, cosa che rende infondata la preoccupazione, largamente diffusa tra i profani, circa gli effetti traumatici dell’addestramento di gruppo. «Avvengono dei cambiamenti nella sensibilità, nella capacità di controllare i sentimenti, nella direzionalità della motivazione, negli atteggiamenti verso il Sé, negli atteggiamenti verso gli altri e nell’interdipendenza» (Carl Rogers, I gruppi d’incontro, pp. 117-118) effetti che, dopo aver provocato agitazione e cambiamenti nell’individuo, «sembra quasi inevitabile che la provochino nelle istituzioni, ed è questa l’esperienza più minacciosa per il dirigente tradizionale». (Ibid., p. 75)
Sommario 7.12
- Introduzione con Yuval Noah Harari (Davos 2026)
- Trailer Mercy – sotto accusa (2026) / Carlo Nordio e le BR
- IOA – Spot 27 – Amitripticina
- ESPERIMENTO ROSENHAM E GUERRA COGNITIVA – Prima parte
- IOA – Spot 28 – Recharge
- Biotech Act: opportunità e sfide per l’Italia e per l’Europa nel nuovo scenario geopolitico (Assemblea di Assobiotec, Roma, Auditorium della Tecnica di Confindustria, 25/6/25; con Fabrizio Greco, presidente Federchimica Assobiotec / Maria Cristina Porta, Direttore Generale Fondazione Enea Tech e Biomedical / Luigi Naldini Direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, professore ordinario di Istologia e Terapia Genica e Cellulare, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano)
- Elbit Systems presents: LANIUS – Search & attack in one (spot di droni da Guerra)
- IOA – Spot 29 – Iraq 2 Odorama
Riferimenti 7.12
- Kalacakra, Raga n° 11 + September Full Moon (Crawling to Lhasa, 1972)
- Negazione, Tutti pazzi (Mucchio selvaggio, 1984)
- Sinéad O’Connor, Drink Before The War (The Lion and the Cobra, 1987)
- Sinéad O’Connor, 8 Good Reasons (I’m Not Bossy, I’m the Boss, 2014)
- Sinéad O’Connor, What Doesn’t Belong To Me (Faith and Courage, 2000)
- Sinéad O’Connor, Three Babies + Feel So Different (I Do Not Want What I Haven’t Got, 1990)
- MGZ, Ho un appuntamento dallo psichiatra (Cambio vita, 1995)
- Kill For Total Peace, Jeu d’échecs (Kill For, 2009)
- La Grande Famiglia, Campo Di Battaglia (Una Città Possibile. Storie di centro e di periferia, 1972)