Episodio 6.10
Prima di affrontare le tavole rotonde cibernetiche delle conferenze Macy, è utile capire quale fosse lo spirito con cui vi si accostarono i “cavalieri della causalità circolare” (Conway-Siegelman, titolo del cap. 7) che stavano introducendo nelle scienze un punto di vista assolutamente rivoluzionario, basato sui nuovi principi della comunicazione scoperti da Wiener ed esposti nel maggio 1942 da Rosenblueth, per cui le informazioni tornano continuamente alla fonte per indicare quanto esse stesse stessero deviando dall’obiettivo e quali correzioni fossero necessarie al sistema per raggiungere lo scopo. La loro «nozione di intenzionalità suonava come un’eresia: l’idea stessa di azione intenzionale sfidava il paradigma di causa ed effetto che dominava la scienza; implicava infatti che nessuna nozione ultima o risultato finale potesse cagionare un’azione precedente nel tempo». I sostenitori di questo schema avevano messo al bando qualunque traccia di intenzionalità tanto negli oggetti inanimati quanto nelle creature viventi: filosofi e scienziati riduzionisti, «seguendo le orme di Russell e Whitehead in Inghilterra, di Wittgenstein e dei suoi epigoni dell’autorevole Circolo viennese dei “positivisti logici” e dei comportamentalisti in senso stretto che dominavano la psicologia americana», nella loro urgenza di conferire maggior rigore alla mente umana «avevano eliminato qualunque riferimento alla stessa parola “mente” e, con essa, all’intero regno soggettivo delle esperienze umane, delle emozioni, della volontà e di altri dibattuti “stati interiori” che non potessero essere immediatamente rilevati dai sensi, descritti matematicamente o verificati in via sperimentale.» (Conway-Siegelman, p. 195-196) E pochi mesi dopo, nell’articolo “Comportamento, fine e teleologia” (Bigelow-Rosenblueth-Wiener, gennaio 1943), oltre all’intenzionalità e alla causalità circolare i tre avevano ripescato da Aristotele il concetto di teleologia o causa ultima: «il loro manifesto divenne una pagliuzza nell’occhio dell’ortodossia regnante» e «fornì una spiegazione logica per la comparsa in natura di comportamenti intenzionali e intelligenti senza ricorrere alla metafisica o all’intervento divino, ed espose un programma sistematico per mettere in pratica i nuovi principi in un’ampia gamma di applicazioni scientifiche e tecniche.» (p. 200)
L’intervento di Rosenblueth aveva colpito tutti e in particolar modo i neurologi. Già da una decina d’anni Lawrence Kubie aveva pubblicato uno dei primi documenti «in cui si sosteneva che nelle reti neuronali del cervello potevano presentarsi onde circolari di attività elettrica» che si sarebbero «mosse lungo percorsi che in ultima istanza le avrebbero riportate al punto di partenza» (L. Kubie, “A Theoretical Application to Some Neurological Problems of the Properties of Excitation Waves Which Move in Closed Circuits”, Brain n° 53, luglio 1930), la cui esistenza era stata confermata pochi anni dopo da Rafael Lorente de Nó del Rockfeller Institute. Il più elettrizzato fu indubbiamente Warren McCulloch. Di quattro anni più giovane di Wiener, dopo aver studiato filosofia e psicologia, divenuto dottore in medicina nel 1927 aveva creato la prima mappa dell’anatomia funzionale della corteccia, ipotizzando che le reti neurali funzionassero con l’attivazione o meno di segnali eseguendo complesse somme matematiche in sequenze elaborate di “affermazioni” elettrotecniche. La sua grandiosa ipotesi «che il cervello umano fosse un piccolo motore elettrico per svolgere operazioni di logica matematica, sembrava spiegare come il cervello eseguisse i processi razionali di inferenza logica, deduzione, calcolo numerico, oltre che le funzioni base di percezione sensoriale e le operazioni di ordine più elevato della mente, come il linguaggio, l’apprendimento e la memoria.» (201-202) Ma a questo punto si era imbattuto in un ostacolo inatteso, qualcosa di assolutamente illogico, l’esistenza all’interno delle articolate reti del cervello di inspiegabili spire di connessioni circolari, che contraddicevano tutto quanto da lui scoperto.
L’enigma restò irrisolto anche dalla sua nuova equipe del laboratorio di ricerca presso l’Istituto neuropsichiatrico della Scuola medica dell’Università dell’Illinois a Chicago, in cui si trasferì alla fine del 1941, finché non incontrò un altro “ragazzo prodigio della matematica”, Walter Pitts. Figlio di proletari, scappò di casa per le percosse del padre andando a vivere per strada. Quando, fuggendo da un gruppo di ragazzi che volevano picchiarlo, si rifugiò in una biblioteca e si nascose tra gli scaffali, trovò i Principia Mathematica: rimase in biblioteca tutta la settimana finché non finì i tre volumi, poi si sedette, scrisse una critica di una lunga sezione del primo volume e la spedì a Russel in Inghilterra. A soli tredici anni fu invitato in Europa da Russel a studiare a Cambridge, poi tornò negli Stati Uniti due anni dopo, a Chicago, dove studiò con Rudolf Carnap, leader del circolo viennese dei positivisti logici che si era da poco trasferito in America. Quando anche McCulloch si trasferì in quella sede, il professore di ingegneria elettrica e biomedica Jerome Lettvin glielo presentò, e poco dopo entrambi si trasferirono ad abitare a casa McCulloch. Nel giro di poche settimane avevano analizzato il flusso dei segnali attraverso le diramazioni del cervello, nel tentativo senza precedenti di «comprendere come il cervello operava per essere il meccanismo dei processi mentali.» (Lettvin, in McCulloch-Sturgis, Collected Works of Warren McCulloch, vol. 1, 1989)
Uscito poco dopo l’articolo di Wiener-Bigelow-Rosenthal, il primo documento firmato McCulloch-Pitts – “Un calcolo logico delle idee immanenti al sistema nervoso” (Bulletin of Mathematical Biophysics, n° 5, 1943) – fu altrettanto profondo e rivoluzionario. Dimostrarono che le tutte le attività «che siamo avvezzi a chiamare mentali sono rigorosamente deducibili dalla presente neurofisiologia», spiegando come le più semplici esperienze sensoriali potessero essere “elaborate” logicamente dal cervello dai segnali condotti all’organo dai recettori della pelle. Inoltre tracciarono il primo modello schematico di una “rete di neuroni” logica provando la correttezza della loro proposizione per cui «ogni idea e ogni sensazione si compie per l’attività di quella rete»; addirittura dimostrarono come potessero essere elaborati i processi mentali più complessi, come l’apprendimento e la memoria, conducendo alla formazione di nuove sinapsi fra i neuroni. Infine, attingendo al nuovo concetto di causalità circolare, costruirono una serie di teoremi che descrivevano l’azione nelle «reti con circoli» neurali dimostrando come queste potessero dar vita a cicli autoalimentati di attività elettrica, e come «quell’attività potesse essere lanciata in un circuito e continuare a riverberare in esso per un periodo di tempo indefinito», fenomeno che secondo loro poteva creare memorie durature attraverso la sola azione elettrica. Circostanza ancor più importante, metteva le reti di elaborazione cerebrali nelle condizioni di «prevedere il futuro in base alle attività presenti», motivo per cui il loro modello spiegava i «sistemi che (…) presentano una condotta finalizzata» nell’uomo e negli altri organismi che possedevano sistemi analoghi.
Stabilirono poi un altro portentoso collegamento. Il loro originale calcolo cerebrale descriveva un nuovo ordine di attività di elaborazione “immanente”, innato al cervello, che si conformava quasi alla perfezione alla definizione data da Alan Turing di calcolatore “universale”, come sintetizzò McCulloch quello «in grado di calcolare qualunque sequenza logica di dati immessi o, per usare le parole di Turing, di calcolare qualunque numero calcolabile.» (Ibid.) Malgrado tutte le intuizioni, i due rimasero ai margini e non destarono l’attenzione della principale corrente dello studio neurologico, e nemmeno quella di filosofi e psicologi; tuttavia il documento si diffuse tra le reti dei matematici e degli ingegneri che lavoravano alla teoria e alla progettazione delle nuove macchine calcolatrici elettroniche, e alla fine il loro lavorò sarà riconosciuto come una tappa fondamentale nell’evoluzione del calcolo digitale, come l’opera fondante nel campo dell’intelligenza artificiale e come catalizzatore cruciale nel progetto postbellico di creare il “primo cervello elettronico del mondo”.
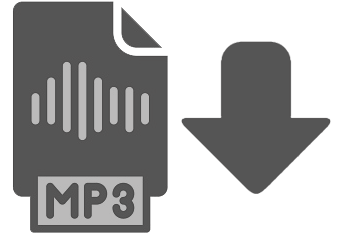 |
Sommario 6.10
- Introduzione con Pekka Lundmark, CEO Nokia
- Caterpillar legge Bruno Geda – S.O.S. Save Our Souls
- Raoul Dalmasso – CIBERNETICA DEL WETWARE. Un’etnografia cyberpunk (Rivista Malamente n°35, gennaio 2025) – PRIMA PARTE
- Il robot “Pepper” della giapponese SoftBank Robotics (TgR Liguria, 10/1/2025)
- Verbania: intossicazione alla festa della Polizia Locale, trovato lassativo (Vco Azzurra TV, 23/1/2025)
Riferimenti 6.10
- Χαΐνηδες (Chainides), Πνοή [Instrumental] + Αναζήτηση [Instrumental] (To drakodonti / O giteftis kai to drakodonti, 2005)
- Χαΐνηδες (Chainides), Κοντυλιές της αυγής + Hitzaz Longa + Outi Taximi Ousak – Kartzigar (O giteftis / O giteftis kai to drakodonti, 2005)
- Cockney Rebel, Death Trip (The Human Menagerie, 1973)
- Steven Stapleton & David Tibet, The Dead Side of the Moon (Musical Pumpkin Cottage, 1996)
- Nurse With Wound, Bone Frequency (con Inflatable Sideshow) + Angle (con Chris Wallis & Peat Bog) + Animal or Vegetable (con Stereolab) (The Swinging Reflective, Favourite Moments of Mutual Ecstacy, 1999)
- The Clockwork Dolls, Compilation of Incomplete Instrumental Sketches [And Then Some] (The Complete Instrumental Collection, 2011)
- Roberto Benigni, L’inno del corpo sciolto (1979)
- Neri Parenti, Natale sul Nilo (2002)
- The Clockwork Dolls, Compilation of Incomplete Instrumental Sketches [And Then Some] (The Complete Instrumental Collection, 2011)
